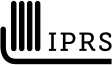"Al di là del disturbo" - Una testimonianza
“Mi presento: mi chiamo Costanza, ho diciannove anni e frequento il corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell’università di Trento; anche se secondo il centro di disturbi alimentari che mi seguiva, in questo momento dovrei essere in una residenza per curare il mio problema. Devo specificare che soffro di anoressia, un disturbo dell’alimentazione che prevede il rifiuto del cibo. Il rapporto complicato tra me e l’alimentazione mi ha portata in quello che il mio psicoterapeuta definisce un vero e proprio viaggio, pieno di peripezie dai quali sono conseguiti insegnamenti di vita. Senza che nemmeno me ne rendessi più di tanto conto, la mia malattia ha preso il sopravvento e come conseguenza sono stata ricoverata nell’Ospedale della città vicino la mia.
Sono rimasta lì per un mese e mezzo, con un tubicino che dal mio naso arrivava fino allo
stomaco. In quel periodo pensavo di aver toccato il fondo, ma mi ritrovai stupita per ciò che accadde poco dopo. Alla scadenza del termine della mia degenza in ospedale, il centro dei disturbi alimentari a cui facevo riferimento mi propose di trasferirmi per un periodo di minimo quattro settimane in una struttura a carattere ospedaliero per gente che, come me, litiga con il cibo. Per i medici del reparto la mia era una situazione fisica al limite della gravità, per cui decisero di estendere la mia permanenza a sei settimane. Mi ritenevo fortunata, ero seguita da un team di specialisti del settore e nel percorso avevo fatto grandi passi avanti.
Solo a posteriori mi resi conto di quanto fossi stata delusa dal sistema.
Fu un programma televisivo a darmi l’illuminazione, si chiama ‘Fame d’Amore’ (e già il titolo dice molto). Il caso volle che venissi a conoscenza del fatto che avevano registrato una puntata proprio nella struttura dove ero stata, scontato dire che la guardai. Se l’intento del programma fosse quello di sensibilizzare su una problematica così comune e importante, il risultato è opposto all’obiettivo.
Ricordo la scena di una ragazza, intenta a piangere davanti al primario del reparto perché
stufa e impaurita dell’aumento degli alimenti tramite flebo. Diceva addirittura di volersele
togliere di dosso. Agli occhi di uno spettatore, quella descritta è una scena drammatica, di
piena sofferenza e nessuno potrebbe negare il contrario. Ma guardiamola dalla prospettiva
di una persona, di qualsiasi età o sesso, che soffre di un disturbo alimentare, in questo caso l’anoressia. Cosa dovrebbe dire se non ‘la mia malattia non è grave come la sua’. Ed è proprio qui che si innesca un meccanismo di autocritica: ‘non sono abbastanza malato, il mio problema non vale quanto il suo’. Così, con molta semplicità, il disturbo si aggrava a livello mentale, fino ad andare ad occupare qualsiasi anticamera del cervello. E quella che è una malattia da sensibilizzare, viene invece romanticizzata. Vedendo quelle scene da fuori, come soggetto che sta lentamente uscendo dall’anoressia, mi sono resa conto che non basta conoscere il problema per comprenderlo. Si possono leggere quanti manuali si desidera, considerare testimonianze, lavorare nel settore, ma non si potrà mai affermare di aver capito cosa passa nella testa di persone come me.
Ricordo un giro medici, quando l’équipe si riunisce per analizzare lo sviluppo della terapia assieme al paziente. In uno di questi momenti tanto temuti il primario del reparto, con
l’intento di fare una battuta mi chiese se il calo di peso in quei primi giorni di ricovero fosse stato dovuto a degli angeli che, prendendolo, lo avessero portato in cielo. Risposi che avevo perso chili perché non mangiavo. Quello che all’apparenza mi sembra un modo di alleggerire la situazione, ora è invece la sintesi perfetta di come non si dovrebbe trattare una problematica del genere.
Il metodo di cura di un disturbo alimentare non dovrebbe incentrarsi sull’aspetto fisico, ma su quello che la magrezza, l’obesità o il vomito nascondono.
Esiste un mondo dentro una persona, che va oltre l’apparenza fisica.
L’ho capito quando sono stata ricoverata successivamente in psichiatria, dove in mezzo a persone psicotiche nessun medico riusciva a cogliere la loro umanità. Lo stesso concetto si applica per strutture di cura o programmi come quello di cui ho parlato precedentemente. Quella che fanno non è corrispettivamente né cura né sensibilizzazione, ma semplice diagnosi. Ti ritrovi con addosso un’etichetta che non descrive te, ma la tua malattia. Diventi tu stesso il male che ti affligge e nessuno si rende conto che oltre quello c’è un essere umano.
E qui mi chiedo perché invece che avere come fine ultimo quello di stabilizzare situazioni complicate, non si ha quello di cercare di capire soggetti come me?
Invece di prescrivere una lista infinita di psicofarmaci si dovrebbe istituire un dialogo tra paziente e medico, o chi per lui. Persone come me puoi anestetizzarle con le medicine per velare il problema, oppure puoi decidere di parlarci.
Capisco che la seconda opzione richiede uno sforzo maggiore della semplicità con cui si scrivere una ricetta per una scatola di Tavor, ma pensiamoci su: non sarebbe più efficace?”
Il nuovo numero della rivista, aperta alle migliori collaborazioni di settore e in rapporto costante con i vari Ordini professionali della cura, si intitola “Lo specchio infranto – rischio e danno nella violenza di genere”.
Il numero, sarà disponibile in free download sul sito della rivista, www.dromorivista.it
Altro da "DROMO":

“La vita cerca legami. Storia di Francesco”
“La vita cerca legami. Storia di Francesco.” Il peso dei

L’accoglienza mediata
“L’accoglienza mediata” di Chiara Peri Qualche considerazione sulla nuova programmazione

La dispersione scolastica nei territori di mafia. I numeri, i contesti, i ragazzi
“La dispersione scolastica nei territori di mafia. I numeri, i
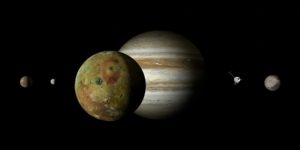
Vax, no-vax e Terzo pensiero
“Vax, No-vax e Terzo pensiero” di Raffaele Bracalenti “La professione

La migrazione che ammala
“La migrazione che ammala” di Chiara Peri La sofferenza psichica

Declinismo, sintomo senile della psicoanalisi contemporanea
“Declinismo, sintomo senile della psicoanalisi contemporanea” di Arturo Casoni Franco

La rivoluzione stanca
“La rivoluzione stanca” di Raffaele Bracalenti La scelta di titolare