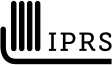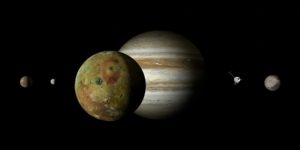"L'accoglienza mediata"
Qualche considerazione sulla nuova programmazione del Fondo Asilo Migrazione Integrazione
Nella programmazione del Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020, che si sta concludendo in questi mesi, si è scelto di investire risorse per “promuovere l’autonomia dei titolari di protezione internazionale e la loro fuoriuscita dal circuito di accoglienza, attraverso la realizzazione di percorsi individuali di inserimento socio-economico”.
L’iniziativa del FAMI ha introdotto almeno due elementi d’innovatività: l’uno riferendosi al tema dell’autonomia, l’altro destinando le iniziative di sostegno specificamente ai soggetti usciti dal sistema di accoglienza. Questo, di fatto, ha prodotto una sorta di salutare disorientamento tra gli operatori, stimolando una riflessione sul loro ruolo; sul senso del funzionamento del sistema SAI/SIPROIMI/SPRAR, che negli ultimi anni ha più di una volta cambiato nome e, in parte, anche mandato; su cosa volesse dire agire sui destinatari degli interventi una volta che questi fossero fuoriusciti dal sistema. Ma, soprattutto, ci si è chiesti quando si potesse considerare il soggetto autonomo, e soprattutto in che senso; come tale condizioni di autonomia potesse essere misurata: se riferendosi a dati concreti, fattuali (contratto di lavoro, contratto di affitto); o invece considerando dimensioni più immateriali (capacità di orientarsi nel contesto sociale; capacità di self-promotion; etc.).
Tutto questo, ha aperto spazi di riflessione che interrogano non soltanto coloro che operano nel sistema dell’accoglienza, ma più in generale tutti coloro che guardano con attenzione ai fenomeni sociali che interessano la nostra comunità. Tale riflessione sull’autonomia risulta particolarmente utile e strategica in un momento in cui, oltre alla nuova programmazione per l’utilizzo delle risorse FAMI per il periodo 2021-2027, si sta predisponendo anche il secondo Piano Nazionale di Integrazione per i Titolari di Protezione Internazionale, dopo quello adottato il 26 settembre 2017.
Pur nell’estrema varietà delle esperienze territoriali, il sistema di accoglienza per i migranti forzati che arrivano in Italia spesso non riesce ad offrire agli accolti un percorso di empowerment, come sarebbe nei suoi obiettivi, ma si traduce piuttosto in un’esperienza di impoverimento delle risorse personali e di disempowerment. Le ragioni naturalmente sono varie e complesse, alcune contingenti e altre strutturali.
Al di là delle analisi puntuali delle specifiche situazioni particolari, però, è utile porsi una domanda di fondo: qual è il mandato specifico di un sistema di accoglienza?
L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare e favorire i percorsi di integrazione dei migranti forzati, coniugando i doveri di assistenza e protezione con la necessità di fornire gli strumenti necessari all’autodeterminazione della persona nel contesto di accoglienza. Ma gli strumenti da utilizzare per realizzare l’obiettivo non sono del tutto chiari.
Il sistema di accoglienza, infatti, non dovrebbe prevalentemente usare mezzi propri, quanto piuttosto attivare i servizi territoriali competenti per ciascun ambito, favorendo una corretta e efficace interazione tra migranti e servizi stessi. Allo stesso tempo però il sistema di accoglienza non ha né potrebbe avere la responsabilità diretta in merito all’effettiva attivazione di tali servizi, né tanto meno è nella posizione di assumere un ruolo attivo nella costruzione dei percorsi specifici dei migranti all’interno dei servizi stessi. Probabilmente nella realtà di molti territori i gestori dell’accoglienza si trovano a fare i conti con servizi di fatto del tutto assenti e a dover supplire carenze che riguardano certamente tutti i cittadini, ma a cui i migranti forzati hanno obiettivamente meno risorse per fare fronte. La pur auspicabile integrazione dei servizi e conseguente coprogettazione dei percorsi rischia dunque di apparire una prospettiva davvero poco realistica.
Nella triangolazione migranti-servizi territoriali- sistema di accoglienza si creano quindi delle ambiguità rispetto alle responsabilità specifiche di ciascuno e questo rischia paradossalmente di depotenziare più che di incrementare la possibilità effettiva del migrante di accedere i servizi. E che dire la comunità in cui tutti questi attori agiscono?
Come è noto, l’integrazione è un processo biunivoco, che passa necessariamente attraverso una negoziazione tra migrante e comunità che lo accoglie. C’è il rischio che l’intermediazione delle strutture di accoglienza finisca per frapporre un filtro, una barriera, tra migrante e comunità, con il risultato di demotivare tanto l’uno quanto l’altra rispetto alla necessità di impegnarsi in un processo che ha indubbiamente le sue complessità e le sue asprezze. Da un lato, infatti, il migrante si trova in una struttura che lo accoglie e in una certa misura lo protegge, in ragione di una sua condizione di svantaggio, e questo rischia di depotenziare la sua spinta a interagire con un contesto più ampio e meno rassicurante. Ma anche la comunità, in qualche misura protetta dall’impatto potenzialmente “disturbante” del migrante, viene di fatto privata di occasioni e opportunità di interagire direttamente con lui. Sarebbero tutte interazioni arricchenti e positive? Verosimilmente, no. Ma la loro assenza contribuisce a creare una distanza che nel tempo rischia di divenire profonda e sostanziale.
Come evitare che questa esigenza di reciproca rassicurazione riduca la motivazione degli attori di implicarsi in un processo potenzialmente faticoso e conflittuale, ma anche necessario? Certamente non possiamo attribuire solo a questo aspetto i tempi sempre più protratti dell’accoglienza e le difficoltà che i migranti forzati continuano a incontrare rispetto a una piena inclusione nelle comunità, ma si tratta di un aspetto su cui vale la pena di fare una riflessione.
Il problema si pone in modo più accentuato – e in qualche misura diverso – per le persone che vivono una condizione di vulnerabilità, come ad esempio il disagio psichico o forme più o meno gravi di dipendenze. In queste situazioni, che hanno indubbiamente un impatto sociale più elevato, i meccanismi espulsivi paiono avere il sopravvento, sia da parte del sistema di accoglienza (che lamenta la mancanza di mezzi e competenze specifiche per far fronte al problema), che da parte dei servizi territoriali (che, gravemente depotenziati e sotto dimensionati rispetto al bisogno, sono riluttanti nell’assumere una responsabilità complessa e multidimensionale), oltre che naturalmente da parte della comunità nel suo insieme.
Quanto più dunque sarebbe necessaria un’assunzione di responsabilità, tanto più gli attori coinvolti finiscono per tirarsi indietro. Paradossalmente, la generale tendenza a protrarre la fase di accoglienza interessa soprattutto le persone meno che ne avrebbero bisogno: laddove invece i bisogni di protezione sono più elevati, il sistema mostra tutti i suoi limiti e finisce per espellere i più vulnerabili, innescando una spirale di marginalità che diventa molto complicato arrestare.
L’idea alla base dell’istituzione dello SPRAR era quella di radicare l’accoglienza dei migranti forzati nelle comunità, facendo sì che i luoghi dell’accoglienza siano a tutti gli effetti luoghi della città. La natura dei luoghi dell’accoglienza ha evidentemente un ruolo nel determinare la qualità della triangolazione migranti-servizi-comunità. Spesso si sottolinea come, quando essi sono luoghi squallidi, non dignitosi, rischino di suggerire un’associazione deleteria tra migrazione e degrado sociale. Bisogna accogliere fino in fondo la sfida di dare ai luoghi piena dignità, senza temere le polemiche e la potenziale conflittualità sociale che nasce dalle proteste strumentali di chi non vorrebbe “i profughi accolti in hotel a 5 stelle”.
Una strada sempre più praticata e potenzialmente vantaggiosa è quella dell’accoglienza diffusa. Bisogna tuttavia essere consapevoli che anche questa modalità presenta delle criticità. L’invisibilità delle strutture abbassa il potenziale conflitto, ma non favorisce di per sé l’interazione del migrante con la comunità. Il lavoro di intermediazione risulta più faticoso e complesso da realizzare.
L’accoglienza diffusa potenzialmente favorisce la precoce autonomizzazione del migrante, ma bisogna anche essere consapevoli che una semplice dislocazione logistica non è sufficiente: è necessario rafforzare le opportunità di inclusione sociale sui territori, con un’attenzione specifica ai migranti forzati, ma anche con la consapevolezza che le comunità nel loro complesso oggi risentono di un deficit di coesione e di capacità di creare connessioni. In questa accezione, l’accoglienza, se pensata con lungimiranza e nella sua complessità, può divenire strumento di crescita, evoluzione e sviluppo.
Parte di un buon processo di accoglienza infatti è riorganizzare e incanalare all’interno dei territori le forze e le energie legate alla paura di perdere per sé servizi e risorse e di confrontarsi con la diversità. Ciò è possibile solo nei contesti locali, dove si vive la quotidianità delle relazioni, dove si affronta l’esistenza nella puntualità delle situazioni che si presentano giorno dopo giorno, dove il dialogo della vita si gioca in piccoli gesti, nelle risposte a necessità concrete e misurabili, a situazioni esistenziali quali la malattia e il disagio mentale.
Il necessario lavoro di mediazione richiesto per una inclusione effettiva non è in fin dei conti che un tentativo di coniugare la complessità del fenomeno migratorio con la complessità del reale e questo comporta l’incontro di persone, ma ha bisogno della creatività di contesti locali che abbiano la voglia e il coraggio di lasciarsi attraversare da presenze inattese. Quando queste condizioni si verificano, l’accoglienza può generare la novità di società ancora più ricche in umanità e spesso anche di risorse economiche e di servizi alla persona.
La complessità, cifra caratterizzante del fenomeno migratorio e di conseguenza – necessariamente – dell’accoglienza, ha bisogno non solo di un approccio multidisciplinare e di una governance multilivello, ma anche di un sincero spirito di collaborazione. Come scrive Richard Sennet (Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Feltrinelli 2012), «la collaborazione può avvenire anche in maniera informale, la gente che si ferma per strada a far due chiacchiere o si incontra al bar e parla del più e del meno non pensa consapevolmente ‘Ecco, sto collaborando’. L’atto di collaborazione si riveste dell’esperienza del piacere condiviso».
Per questo negli ultimi anni diversi progetti e programmi volti a promuovere l’autonomia dei rifugiati hanno colto l’importanza di promuovere contatti significativi con la popolazione locale, sperimentando metodi che facilitino, incoraggino e accompagnino la creazione di relazioni interculturali calde che non avvengono (facilmente) nella vita di tutti i giorni. Quando i migranti hanno occasione di ampliare e diversificare le proprie reti sociali, oltre a aumentare le opportunità di inserimento abitativo e lavorativo per le singole persone, si registrano anche ricadute importanti sulla comunità nel suo complesso. E’ evidente che questa responsabilità non può essere demandata esclusivamente al sistema di accoglienza, ma allo stesso tempo è importante contrastare una certa tendenza all’autoreferenzialità del sistema stesso.
All'interno anche il secondo numero della rivista dal titolo:
“LA RIVOLUZIONE STANCA”,
disponibile in edizione digitale gratuita!
Il nuovo numero della rivista, aperta alle migliori collaborazioni di settore e in rapporto costante con i vari Ordini professionali della cura, si intitola “La rivoluzione stanca” ed è dedicata alla salute mentale con i contributi di Marco D’Alema, Nerina Dirindin e molti altri professionisti.
Il numero, sarà disponibile in free download sul sito della rivista, www.dromorivista.it.