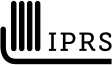a cura di Attilio Balestrieri e Raffaele Bracalenti
Può sembrare scontato affermare che le modalità con cui gli adulti si prendono cura dei bambini sono fortemente influenzate da fattori culturali e come tali vanno considerate. Tuttavia, quest’affermazione contraddice un’opinione di senso comune assai diffusa, secondo cui, invece, non v’è nulla di più naturale del prendersi cura dei bambini. Le osservazioni di Rousseau sulla brutalità degli stili di fasciatura dei bambini piccoli, l’orrore che oggi si prova nei confronti di strumenti educativi carichi di violenza e l’attuale diffusione delle forme di incuria sono solo alcune tra le moltissime osservazioni che mostrano quanto lavoro ci sia ancora da fare per garantire ai bambini processi di crescita realmente in grado di promuovere e garantire il loro benessere. Gli adulti fanno fatica a capire, rispettare, aiutare i bambini.
Non è un caso che, a partire dagli studi dei coniugi Kempfe o dai lavori di psico-storia dell’infanzia inaugurati da Lloyd deMause, sono progressivamente aumentate le riflessioni e le osservazioni sui rischi cui sono esposti i bambini sin dalla più tenera età, anche nei luoghi idealmente preposti alla loro cura e benessere, qual è – o dovrebbe essere – la famiglia.
E tutto ciò ha esortato in maniera crescente a meditare sulle forme di violenza, esplicita o implicita, fisica o psicologica, cui i bambini sono esposti, nonché sulle conseguenze che tali violenze producono sul loro sviluppo psicologico e sui segni di tale violenza che nondimeno si riscontrano nella clinica dell’adulto.
È dunque costante l’attenzione a cosa possa rappresentare un trauma, sia esso un’esperienza unica e occasionale, o invece ripetuta e costante; così com’è costante l’attenzione a cosa significhi la riattualizzazione traumatica legata al ricordo dell’esperienza dolorosa; o, ancora, l’attenzione all’insorgere disfunzionale di risposte neuro-fisiologiche legate alla sofferenza, al terrore ed all’annichilimento, che si provano nel trauma.
Ed altrettanto costante è l’attenzione alle funzioni e qualità del caregiver, intese come possibile risorsa per favorire il superamento, l’elaborazione e la “mentalizzazione” dell’esperienza traumatica, da parte del bambino che la sperimenta. Tutto ciò occupa oggi gran parte della ricerca clinica sul trauma e vede operarsi una singolare convergenza degli apporti di costrutti teorici diversi, provenienti dalle neuroscienze, dal cognitivismo e dal comportamentismo, nonché dalla psicoanalisi.
In particolare, si tenterà qui di ripercorrere, in maniera parziale e necessariamente frammentaria, il percorso compiuto su questo tema dal pensiero psicoanalitico che, sin dai suoi esordi, ha individuato nel trauma infantile un’esperienza centrale per la costituzione della vita psichica ma, nel corso dei decenni, ha progressivamente spostato la sua attenzione dalla natura quasi intrapsichica e inevitabile di quest’esperienza, ai suoi aspetti invece più legati al contesto relazionale ed intersoggettivo in cui essa accade, leggendola anche come fatto, se non evitabile, almeno modulabile, proprio in virtù delle capacità dei caregivers, o al contrario, come fatto incontrollabile, che scaturisce e diviene traumatico, per l’appunto a causa della relazione con i caregivers, quando costoro mostrano incapacità o franca patologia nel loro rapporto con i bambini.
In questo senso la riflessione psicoanalitica offre oggi contributi essenziali per l’approccio al bambino traumatizzato, per comprendere quali forme di aiuto è possibile fornirgli e quali forme di sostegno al recupero di capacità affettive e relazionali è possibile fornire ai diversi caregivers.
Da sempre la psicoanalisi si occupa di “traumi” ma i recenti sviluppi teorici e clinici del pensiero psicoanalitico, anche alla luce dei punti di intersezione e persino di integrazione con gli apporti provenienti dalle neuroscienze, hanno condotto ad una lettura assai più complessa ed articolata del trauma infantile, giungendo per molti versi a modificare sia il modo in cui si guarda al bambino, sia l’approccio globale alla sofferenza infantile, soprattutto nelle forme più gravi (quelle meno accessibili ai tradizionali approcci terapeutici del passato).
Ed all’interno di quest’evoluzione della teoria e della clinica è divenuta centrale l’attenzione al tema del trauma, inteso come processo che mobilizza livelli psichici, neurobiologici e relazionali, fino ad incidere profondamente sui processi stessi di “mentalizzazione”. Nei traumi infantili sembrano infatti dominare gli elementi pre-verbali e pre-simbolici, ancorati ai sistemi sensoriali, percettivi e motori, alle reazioni somatiche o viscerali ed ai livelli più elementari delle emozioni, col risultato che dell’esperienza traumatica si conserva una sorta di traccia mnestica degli stati fisici ed emozionali legati ad essa – cioè una traccia connessa all’operatività delle memorie procedurali o implicite che, come oggi si ritiene, hanno nell’infanzia un ruolo preminente – piuttosto che un ricordo vero e proprio, cioè un ricordo per come esso è comunemente inteso (un evento che la memoria è in grado di esplicitare e verbalizzare). In sintesi, nella dinamica del trauma sembra entrare in gioco qualcosa di poco rappresentabile e poco accessibile a quella dimensione del ricordo che appartiene allo spazio della memoria esplicita, dichiarativa e verbale. Qualcosa che, pertanto, è come se rimanesse “fuori del tempo”.
Per meglio comprendere i vari apporti che sostengono l’attuale concezione psicoanalitica del trauma è utile ripercorrere il loro sviluppo, in una sintetica ricognizione.
Esordi: Freud e Ferenczi
La psicologia prende in prestito il termine trauma – che in greco antico significa ferita con perforazione o lacerazione – dalla medicina e dalla chirurgia, nel cui ambito indica una lacerazione del tessuto cutaneo, oppure una lesione di un organo interno, senza perforazione degli strati superficiali (ad esempio: traumi addominale o cerebrale cosiddetti “chiusi”) nonché, in alcuni casi, le conseguenze di una violenza esterna sull’insieme dell’organismo. La psicoanalisi, sin dalle sue origini, ha ripreso l’idea del trauma trasponendo sul piano psichico i tre significati che questa parola ha in medicina e chirurgia: quello di shock violento, quello di lacerazione, quello di insieme di conseguenze sull’organismo nel suo complesso.
Ecco perché parliamo di trauma per indicare un evento della vita di una persona, che può intervenire all’improvviso o in maniera reiterata, e che si caratterizza per la sua intensità, per l’incapacità del soggetto di rispondervi adeguatamente, nonché per la viva agitazione e per gli effetti durevoli che esso complessivamente provoca nell’organizzazione psichica.
In accordo con Sigmund Freud, la nozione di trauma rinvia innanzitutto agli aspetti “economici” del funzionamento mentale: un’esperienza violenta (una forte emozione che interviene nei limiti di un breve lasso di tempo) o un accumulo di eventi singolarmente tollerabili (reiterazione di singoli eventi, ciascuno dei quali da solo non agirebbe come trauma) producono un afflusso di stimoli talmente forte (rispetto alla tolleranza dell’apparato psichico) che la sua liquidazione o elaborazione nel modo usuale non riesce, così che il principio di costanza viene messo in scacco (poiché l’apparato stesso è incapace di scaricare l’eccitazione) e si determinano perciò disturbi permanenti nell’economia energetica della psiche (Introduzione alla psicoanalisi, 1916).
Dal punto di vista strutturale, Freud attribuisce inizialmente il trauma ad un evento personale della storia del soggetto, collocabile nel tempo e soggettivamente significativo, in rapporto all’intensità delle emozioni che esso è in grado di suscitare in quel particolare soggetto. Nel senso che la traumaticità di un “fatto” è determinata anche dalla peculiare “sensibilità”, o “suscettibilità”, di ogni persona. Ad ogni buon conto, ciò che rende impossibile il superamento di un’esperienza e determina che essa permanga alla stregua di un corpo estraneo all’interno dello psichismo (cioè ciò che conferisce le caratteristiche del trauma a quell’esperienza) è in primo luogo il conflitto psichico, nella misura in cui impedisce al soggetto di integrare nella sua personalità cosciente quell’esperienza che gli giunge dall’esterno.
L’accento posto da Freud sul conflitto e sul tema della difesa (l’insieme dei meccanismi che consentono di “integrare” la peculiare intensità di alcune esperienze) lo portano a postulare che l’evento traumatico – che in molti casi è peraltro connotato da un carattere essenzialmente sessuale – susciti nell’Io una reazione difensiva e, più in particolare, l’attivazione di una difesa “fisiologica”, qual è la rimozione, che opera secondo il processo primario. E questa concezione apre la via all’idea di eventi esterni che assumono valenza traumatica solo – o principalmente – nella misura in cui sono in grado di attivare o riattivare fantasmi interni, col conseguente afflusso di forti eccitazioni pulsionali.
In Al di là del principio di piacere (1920) Freud torna sulla definizione “economica” del trauma come lacerazione ed ipotizza che un afflusso eccessivo di eccitazione possa mettere fuori gioco – ancorché parzialmente – persino il principio di piacere, subordinandolo ad un’impellenza più urgente, che l’apparato mentale in alcuni casi è chiamato ad ottemperare: legare le eccitazioni ai fini di una scarica successiva. Il tema della coazione a ripetere (di frequente riscontro in un vasto insieme di fenomeni clinici) conferma questa sorta di “limite” del principio di piacere, mostrando come il funzionamento del principio di piacere sia anch’esso dipendente da una sorta di pre-condizioni di base, che per l’appunto il trauma può pregiudicare. E qui per trauma non s’intende più – o non s’intende soltanto – una semplice perturbazione dell’economia libidica (il principio di costanza di cui si diceva prima) bensì una radicale minaccia per l’integrità del soggetto. Qualora sussista o si paventi tale minaccia, il principio di piacere è come sospeso, o messo tra parentesi. La pulsione vitale primaria coincide sì con la ricerca del piacere ma a patto che sussistano le condizioni – ancorché minime – tali da garantire la vita stessa.
Sulla stessa linea, la teoria dell’angoscia del 1926 (Inibizione, sintomo angoscia) attribuisce all’Io la funzione di lanciare il “segnale d’allarme” per evitare di esser travolto dall’insorgenza di una situazione traumatica in cui si troverebbe indifeso (angoscia automatica). E l’Io è suscettibile sia agli attacchi provenienti dall’esterno, sia a quelli provenienti dall’interno, cioè le eccitazioni pulsionali, poiché entrambi gli attacchi sono potenzialmente traumatici. In ogni caso, il nucleo del pericolo risiede comunque in un incremento, oltre la soglia di tollerabilità, di quella tensione secondaria all’afflusso di eccitazioni interne che necessitano di essere liquidate.
Come si vede, la nozione di trauma proposta da Sigmund Freud poggia su una base prevalentemente “energetica” e si collega principalmente alla rappresentazione “interna” ed al ruolo delle fantasie inconsce. L’evento traumatico “reale” ha senz’altro una sua rilevanza ma ciò che conta di più è la rappresentazione interna elaborata dal bambino, dunque il ruolo delle fantasie inconsce (edipiche).
In altre parole: il trauma non agisce direttamente, bensì è tale nella misura in cui attiva fantasmi interni già presenti, risvegliando un’eccitazione pulsionale. A fronte di questa centralità della dimensione “interna”, o intrapsichica, che senz’altro caratterizza la concezione freudiana del trauma, sia i contemporanei del maestro viennese, sia i suoi successori, nell’ambito dell’ampio processo di rivisitazione delle modalità di sviluppo, costruzione e strutturazione della psiche, hanno altresì rivisitato ed integrato con nuove prospettive il modo di intendere la nozione di trauma, richiamando l’attenzione anche sul ruolo nondimeno centrale giocato dalle determinanti ambientali e relazionali, con riguardo ovviamente alla potenziale traumaticità delle relazioni primigenie e strutturanti la vita dell’essere umano.
Tra i contemporanei di Freud, ha conosciuto recente fortuna la riscoperta di un Autore, che certamente più di altri si è soffermato sul punto: Sandor Ferenczi.
Negli stessi anni in cui trovava crescente affermazione la psicologia dell’Io, quest’Autore ha concentrato i propri interessi sull’area che precede la formazione delle strutture intrapsichiche, proponendo di considerare l’ambiente, cioè lo spazio relazionale in cui il nuovo nato viene accolto, non solo nella sua funzione di frustrazione dell’insaziabilità delle pulsioni (da cui si sviluppano le strutture psichiche) ma altresì nella sua funzione di “agenzia” che interviene per porre rimedio ai danni: l’aiuto offerto, ad esempio, dal grembo materno o dall’abbraccio dell’adulto rende possibile quel rilassamento che consente di superare un trauma anche intenso. Si tratta di un aiuto indispensabile per mettere in moto un lavoro interno di “riparazione”, svolto dalle risorse di cui il nuovo nato dispone. In questa luce, il vero trauma dei bambini è sperimentato laddove l’adulto non sa offrire loro l’appoggio di cui hanno bisogno per accedere alla loro facoltà di ripararlo, come accade nei momenti o nelle situazioni di abbandono o solitudine.
Qui la psiche del bambino tende a scindersi in una parte danneggiata ed un’altra che soccorre, come a vicariare le funzioni dell’oggetto edipico assente. Con parole semplici, si può affermare che, da questo punto di vista, il trauma si colloca in un contesto relazionale e può esser letto attraverso l’accostamento tra ciò che accade nella mente del bambino (e che per molti versi le conferisce una struttura) e ciò che si verifica nell’interazione tra il bambino e l’ambiente, cioè nell’incontro tra le necessità del bambino e le risposte offerte dagli adulti di riferimento. Se dunque l’evento traumatico si colloca nella relazione tra i bambini e gli adulti significativi, il trauma psichico non è tale perché produce un’idea, bensì perché irrompe in un mondo di relazioni e significati che il bambino sta costruendo, sconvolgendolo e disorganizzandolo, fino a mettere in scacco, certamente in misura più o meno intensa, le “capacità riparative” di cui il bambino dispone.
Più specificamente, Ferenczi osserva ed acutamente descrive adulti che, in contrasto con le aspettative dei bambini, possono assumere condotte ad un tempo eccitanti, terrorizzanti o dolorose. E propone anche esempi in cui tale condotta dell’adulto viene minimizzata, giustificata, travisata o misconosciuta dall’adulto stesso, privando in tal modo il bambino di conforto o riconoscimento in ordine a quanto da lui esperito, così che il bambino resta disorientato e confuso. In base a queste intuizioni ed osservazioni, la nozione di trauma si amplia e viene ad abbracciare, oltre agli eventi “eclatanti”, la vasta dimensione dei misconoscimenti, delle incomprensioni ed aspettative genitoriali su cui si è successivamente concentrata la tradizione degli studi cosiddetti “transgenerazionali”.
Ad ogni buon conto, al di là dei traumi parziali già accennati da Freud e prima ricordati, con Ferenczi comincia a delinearsi più chiaramente l’idea del traumatismo precoce a cui il bambino può essere esposto, non solo in conseguenza dei comportamenti cosiddetti perversi o violenti degli adulti (gli eventi “eclatanti” prima accennati) ma in tutte le varie condizioni di incuria e mancato o inadeguato accudimento. Ed appare evidente l’influenza patogena della dimensione per così dire “micro” degli eventi che, seppur non rilevanti singolarmente, assumono valenza assai significativa retrospettivamente, ove siano reiterati nel tempo.
Sarà Masud Khan, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, a precisare il concetto di “trauma cumulativo”, che indica la sottile tessitura delle tensioni a cui il bambino è sottoposto nella sua condizione di dipendenza dalla madre. Una tessitura costituita da fattori ambientali apparentemente irrilevanti ma costantemente ripetuti e che, sebbene possano sembrare innocui ed impercettibili, sono nondimeno in grado – proprio perché reiterati – di mettere in moto una vera e propria destrutturazione dello sviluppo psichico.
Il cuore e l’attualità di quanto evidenziato da Ferenczi risiede nel fatto che la patogenicità del trauma (al di là della gravità o dell’intensità dell’evento in sé) risiede nel disconoscimento, o diniego, di quanto accaduto, da parte dell’adulto. L’esser creduto e sostenuto dall’ambiente, cioè dagli adulti di riferimento, diviene così il principale fattore protettivo, per un bambino abusato o traumatizzato, dall’insorgenza di difficoltà di adattamento. E ciò vale anche nello specifico dell’abuso sessuale: su questo tema, l’Autore fa notare la confusione tra il linguaggio della tenerezza e quello della seduzione più o meno violenta, sostenendo che se ai bambini che giustamente chiedono tenerezza s’impone più amore di quel desiderano, ovvero un amore diverso da quello che si aspettano, ciò può avere le stesse conseguenze patogene che derivano dalla privazione di amore.
Gli storici della psicoanalisi, fin nel passato prossimo, si sono forse troppo e troppo a lungo concentrati sull’irriducibilità delle divergenze tra Freud e Ferenczi relative per l’appunto alla questione della genesi del trauma infantile. A loro dispetto è oggi lecito affermare che gli apporti sia di Freud, sia di Ferenczi, seppur pongano l’accento su dimensioni e componenti diverse di questo tema, sono andati incontro ad un destino univoco, nel senso che entrambi sono per molti versi confluiti nell’alimentare l’interesse della psicoanalisi, sul piano teorico e clinico, per le complesse interazioni tra mondo interno e mondo esterno. Interazioni che contribuiscono a configurare il trauma come tale, all’interno dei processi comunicativi ed affettivi, cioè nel complesso delle dinamiche relazionali, anche familiari. Ed in quest’ambito si pongono, ad esempio: l’attenzione alle dinamiche intrapsichiche relative alla gestione della rabbia, brillantemente descritte da Melanie Klein; nonché la nota figura della “madre sufficientemente buona”, messa a punto da Donald Winnicott, indispensabile per consentire al bambino l’elaborazione delle proprie esperienze.
Memoria del trauma e trauma della memoria
Lungi dall’essere concepito alla stregua di conseguenza meccanica di una lesione o di un “urto”, l’entità e la qualità del danno, che caratterizza come tale un trauma, vengono oggi poste in relazione al mondo degli adulti da cui il bambino dipende, poiché il trauma indica e comprende le reazioni del tessuto interumano in cui è inserito chi lo subisce. L’aiuto che il bambino riceve – o non riceve – dai suoi “oggetti edipici”, cioè la risposta che essi gli forniscono, è tutt’uno col trauma, poiché è questa risposta che viene interiorizzata. E quando o laddove la risposta è inadeguata, la domanda resta sospesa. L’esperienza vissuta, ancorché passata, non si conclude ma tende a ripetersi, nella continua e quasi ossessiva ricerca di una “riscrittura” della scena iniziale. Tutto ciò per dire che i recenti contributi provenienti dalle neuroscienze tendono a confermare quanto osservato già da Freud e da Ferenczi, seppur da prospettive diverse, in merito alla memoria traumatica.
Non più o non solo deposito di dati, né replica di eventi, la memoria è oggi intesa come processo dinamico e flessibile. Si parla infatti di “memoria trasformazionale”, per indicare il suo carattere ritrascrittivo, in base a meccanismi di continua e fluida ricategorizzazione associativa, che rendono mutevoli le sue mappe. In una battuta: il passato non è necessariamente concluso ed immodificabile ma può essere riscritto, dunque cambiato. Non solo: l’aspetto dinamico della memoria va ravvisato anche nell’importanza del dimenticare, inteso come operazione indispensabile per accedere alla possibilità ed alla capacità di ricordare le cose nuove che si apprendono giorno per giorno.
Questa concezione della memoria, ben prima che la neurobiologia ne approfondisse il sostrato biologico, appartiene da sempre al sapere psicoanalitico.
Già Freud aveva intuito il carattere trasformazionale e plastico della memoria, racchiuso nella parola Nachtraglichkeit, tradotta in italiano con i termini “posterità” o “posteriorità”, con riferimento al “senso retroattivo” cui essa sembra alludere. E si deve a Jaques Lacan il merito di aver richiamato l’attenzione sull’importanza di questo termine, che egli rende in francese con l’espressione après coup.
L’idea di Nachtraglichkeit ricorre in numerosi passi dell’opera freudiana, per indicare che è peculiare della temporalità e causalità psichica il fatto che esperienze, impressioni e tracce mnestiche vengono rielaborate successivamente, in funzione di nuove esperienze o dell’accesso ad un altro grado di sviluppo. Esse possono allora acquisire, oltre ad un nuovo senso, una nuova efficacia psichica. E ciò vale anche per i traumi sessuali infantili, che secondo Freud non producono effetti all’epoca in cui si verificano ma lasciano una traccia psichica e si riattivano più tardi, cioè quando, in seguito ai cambiamenti puberali, il ricordo sviluppa una potenza del tutto assente nell’episodio originale.
La concezione freudiana della “posterità” è in sintesi caratterizzata da tre aspetti: non è l’esperienza in sé ad esser rielaborata posteriormente, ma in primo luogo ciò che, al momento in cui è stato vissuto, non ha potuto integrarsi pienamente in un contesto significativo (il modello di tale vissuto è l’evento traumatizzante); la rielaborazione posteriore viene precipitata dal sopraggiungere di successivi eventi e situazioni o da una maturazione organica, che permettono al soggetto di accedere ad un nuovo tipo di significati e di rielaborare le sue operazioni precedenti; l’evoluzione della sessualità, con gli sfasamenti temporali che essa comporta nella specie umana, è il fattore principale che favorisce il fenomeno della “posterità” (Progetto di una psicologia, 1895 e aggiunte del 1917 alla discussione del Caso clinico dell’uomo dei lupi).
Dunque il ricordo di un trauma può diventare patogeno nella sua ritrascrizione successiva, perché Freud ritiene, a buon diritto, che il ricordo non è registrato una volta sola, bensì tradotto più volte nelle varie epoche della vita e – aspetto ancor più interessante – “riscritto” ogni volta, in virtù della facoltà della mente di riattualizzare il passato e ricreare, mentre le rivede a posteriori, le proprie memorie.
Inoltre, in base alle sue prime osservazioni dell’amnesia infantile, Freud sosteneva che i ricordi precoci dei traumi infantili non fossero rappresentabili verbalmente, infatti la traccia di tali traumi appariva reperibile solo nei sintomi della nevrosi (la nevrosi cui l’adulto va incontro in relazione al trauma infantile) e non già nel ricordo cosciente. Oggi i neurobiologi danno evidenza di come non vi siano ricordi espliciti della primissima infanzia, perché il sistema che li forma non è ancora pienamente sviluppato. È questo il sistema della memoria esplicita, dichiarativa, di tipo verbale, il cui sostrato biologico risiede nei circuiti neuronali tra l’ippocampo e la corteccia cerebrale, che si sviluppano verso il terzo anno di vita. In età più precoci e probabilmente già nel corso della vita intrauterina è invece operativo un altro tipo di memoria (mediata da numerosi sistemi tra cui quello connesso ai circuiti dell’amigdala) in grado di processare emozioni chiave quali paura e rabbia, che prende il nome di “memoria implicita o procedurale” ed è qualitativamente differente dalla “memoria esplicita o dichiarativa”, perché registra stati somatici ed emozionali non accessibili alla coscienza. Seppur non accessibile alla coscienza, la memoria implicita o procedurale tende a lasciare un’impronta indelebile e, a giudizio dei neurobiologi, i ricordi traumatici sembrano impressi a fuoco nel sistema nervoso centrale e probabilmente ci accompagnano per tutta la vita.
Quest’idea di ricordo non cosciente ma che resta come conficcato nel corpo trova certamente un antecedente nell’osservazione clinica di Ferenczi, che l’ha per molti versi preconizzata laddove constatava come le esperienze traumatiche infantili siano per lo più legate ad un livello esclusivamente somatosensoriale. Cioè non lasciano ricordi coscienti ma sensazioni e reazioni corporee.
Per Ferenczi non v’è ricordo cosciente di qualcosa che cosciente non è mai stato. E la ricerca teorica e clinica più recente conferma l’impossibilità di simbolizzare ed elaborare quelle esperienze terrificanti, al cui dominio appartiene anche ciò che si chiama trauma. Tali esperienze, nella misura in cui comportano un trauma sui sostrati biologici che mediano la memoria implicita o procedurale, rimangono prive di rappresentazione semantica e non riescono ad organizzare la memoria in simboli. Restano quindi a livello somatosensoriale e si esprimono in disagi somatici, disturbi comportamentali, incubi e quant’altro. Sono cioè rappresentate e rappresentabili solo nelle forme proprie della memoria implicita o procedurale e non già attraverso le parole della memoria esplicita o dichiarativa.
Oggi soffia il vento del nuovo, fatto anche di ciò che Peter Fonagy chiama “fertilizzazione crociata” tra diverse discipline. Un vento che, mentre muove di nuovo le vele della psicoanalisi verso la via del largo, mostra nel contempo quanto i padri fondatori hanno avuto lo sguardo lungo, nel senso che, riscoprendoli e ritrascrivendo la loro memoria, ci accorgiamo di come essi sono stati in grado di vedere molto lontano, seppur con i soli strumenti dell’osservazione clinica.
Davvero poetiche le parole di Sandro Gindro, scritte sul finire degli anni Novanta de Novecento, in tema di Antinomie della memoria:
La recente clinica del trauma e degli stati dissociativi, anche alla luce degli apporti provenienti dalla ricerca sull’infanzia e della neurobiologia, si spinge a formulare l’ipotesi suggestiva di considerare le esperienze traumatiche come elementi costitutivi di un inconscio individuale “non rimosso”, che è diverso dall’inconscio individuale freudiano, generato dal lavoro della rimozione, proprio perché viene acquisito come reattività individuale della mente, in grado di operare prima che si sia sviluppata quella funzione dell’Io capace di attivare la rimozione.
Trauma e mentalizzazione
Oltre alla fertilizzazione crociata con le neuroscienze, lo sviluppo dei settori della ricerca psicoanalitica che si occupano di teoria dell’attaccamento ha anch’esso contribuito ad avviare convergenze tra psicoanalisi e cognitivismo, offrendo opportunità di confronto reciproco di fronte a problemi clinici comuni.
In particolare Peter Fonagy ha sottolineato che l’armonia nella relazione di attaccamento tra madre e bambino favorisce lo sviluppo del pensiero simbolico e che la presenza di una base sicura contribuisce al processo di “mentalizzazione” precoce. Il termine “mentalizzazione” indica quella funzione riflessiva di ciò che Winnicott chiama “Sé”, da cui dipende la capacità di comprendere il proprio e l’altrui funzionamento, in termini di stati mentali (emozioni, desideri, idee, controllo degli impulsi e coscienza di sé stessi). Lo sviluppo precoce del processo di mentalizzazione è mediato dalle relazioni di attaccamento con i caregivers, i quali dovrebbero essere a loro volta in grado di mentalizzare, cioè dovrebbero riuscire ad essere amorevoli e riflessivi, ponendo in tal modo le basi per un attaccamento sicuro. Il bambino necessita della presenza costante di un adulto che lo aiuti a sperimentare ripetutamente i suoi pensieri e ciò richiede che tali pensieri trovino a loro volta una rappresentazione nella mente dell’adulto, affinché possano essere da quest’ultimo orientati nella realtà. È solo attraverso questa forma di “conoscenza” della mente dell’altro, all’interno di una relazione intersoggettiva, che il bambino sviluppa il pieno possesso della natura stessa degli stati mentali. Il bambino giunge a conoscere la mente del genitore – e la mente in sé – nella misura in cui il genitore riesce a comprendere e contenere gli stati mentali del bambino. Una formulazione verosimile di ciò che accade al bambino è la seguente: “se la mamma pensa a me come a qualcuno che pensa, io esisto come essere pensante”, perché questa rappresentazione che il bambino vede riflessa nell’adulto sarà internalizzata per formare il Sé. Quando la capacità riflessiva del caregiver adulto lo mette in grado di cogliere le attitudini intenzionali del bambino, quest’ultimo avrà l’opportunità di trovare se stesso nell’altro, nel senso di trovare se stesso come soggetto capace di mentalizzare.
In sintesi: il bambino impara ad elaborare l’esperienza del proprio mondo percettivo ed emotivo in virtù delle modalità relazionali espresse dal caregiver, cioè la sensibilità, responsività e disponibilità di quest’ultimo. Tutto ciò per dire che laddove questa capacità degli adulti di riferimento è compromessa, così come nei casi di abuso o trauma infantile, viene meno la possibilità, per il bambino, di sperimentare adeguatamente i propri stati mentali, attraverso l’identificazione con lo stato mentale dell’oggetto adulto. I bambini che nascono e crescono in contesti poco favorevoli e sono perciò esposti a quella dimensione traumatica descritta parlando di “trauma cumulativo” tendono a reagire all’impatto di questi traumi ricorrendo ad un sistema di meccanismi di difesa primitivi, basati sulla scissione, che consentono loro di allontanare l’angoscia ma, contemporaneamente, vengono ad ostacolare o peggio arrestare il processo di mentalizzazione precoce, essenziale per il pieno e corretto sviluppo della psiche.
Trauma, dissociazione, ripetizione
Si è a questo punto di fronte ad una concezione in cui domina, al di là del trauma in sé, un’idea di sviluppo traumatico che accompagna e contraddistingue la storia di soggetti esposti ai traumi cumulativi dell’infanzia e che delinea una sorta di sindrome, il cui fondamento psicopatologico è costituito da processi mentali dissociativi.
Philip Bromberg ha recentemente richiamato l’attenzione sul punto, con la nozione di “trauma evolutivo”, che consolida un sistema di stati Sé dissociati. Secondo la definizione di quest’Autore, il trauma consiste in una precipitosa distruzione del senso di continuità del Sé, cioè una minaccia schiacciante alla sua integrità accompagnata da ansia di annichilimento, in situazioni dalle quali non c’è speranza di protezione, sollievo o rassicurazione. Nelle situazioni in cui quest’esperienza è prolungata e violenta (come per esempio nelle guerre, nelle deportazioni o in disastri naturali) oppure laddove lo sviluppo del Sé appare pregiudicato da un contesto sfavorevole per un bambino (come ampiamente descritto sopra) il livello di attivazione affettiva diviene troppo intenso per poter essere mentalizzato ed anche il fisiologico processo di rimozione si dimostra insufficiente. L’unica via che rimane è la dissociazione dell’esperienza e, con essa, di una parte del Sé. Questa parte rimarrà separata e non accessibile al ricordo ed alla funzione riflessiva della mente e potrà essere “ricordata” solo attraverso l’azione, come tendenza a ripetere con nuovi materiali la situazione traumatica dissociata o, più esattamente, il complesso insieme di trauma e reazioni, adattative ed insieme patogenetiche.
Trauma e dissociazione sono concetti strettamente associati in psicopatologia, poiché la dissociazione rappresenta una sorta di “fuga quando non c’è via di fuga” e, nel caso dei traumi relazionali e dell’attaccamento disorganizzato, è anche il segno di una frattura nei processi di sintesi e integrazione degli stati affettivi che normalmente producono un senso di sé coerente e coeso. In sostanza, la potenza annichilente del trauma, soprattutto se cumulativo, dunque evolutivo, unitamente al freezing che ne consegue, attivano risposte per così dire primitive, sul modello attacco-fuga dei riflessi neurologici periferici elementari. E vale sottolineare che il ricorso a queste reazioni arcaiche, seppur abbia un significato difensivo (la fuga quando non c’è via di fuga) esita altresì in un’inibizione dello sviluppo di quei processi difensivi dell’Io più avanzati, o più sofisticati, che non riescono a sovraimporsi ai precedenti. Così inteso, il trauma rappresenta una frattura inibitoria dei processi superiori, che lascia operative le modalità di funzionamento mentale più arcaiche e destinate a divenire obsolete nel corso dello sviluppo. Ma l’assenza di mentalizzazione, cioè la persistenza attiva di modalità arcaiche di regolazione affettiva, continua pur sempre a rappresentare, per molti versi, una risposta adattativa, ancorché rudimentale: il miglior adattamento possibile per quel particolare bambino, con la sua particolare storia evolutiva, perché la possibilità di non mentalizzare gli consente comunque di prendere le distanze da un che di incomprensibile e sovrastante le sue capacità psichiche di farvi fronte. Al di là del trauma in sé, l’effetto dirompente risiede nel danno che esso apporta sulla capacità di sviluppare strutture psichiche più evolute, in grado di poterlo elaborare mentalmente.
Lo sviluppo traumatico, che segna la vita del soggetto e resta iscritto nel corpo, comporta in conclusione un duplice effetto: la persistenza di contenuti “non pensabili”, dissociati, che costantemente procura lacerazioni; oppure una sorta di coazione ad agire e ripetere reazioni terrifiche di disgregazione, annichilimento e quant’altro. È frequente infatti il riscontro di un’eco perpetua del trauma, che resta come fissato e sembra richiedere la ripetizione: molte persone traumatizzate si espongono compulsivamente a situazioni analoghe a quelle esperite in un passato, ancorché remoto, in cui è possibile giocare il ruolo sia di vittima, sia di autore, riproducendo il ciclo della violenza. Ecco che l’Io non è più abusato ma abusante, ribaltando la passività in attività e sostituendo la paura e la sensazione di impotenza con un’illusione di onnipotenza. Questo elemento ripetitivo può esprimersi, come noto, anche nei sogni ricorrenti, nella fissità del gioco post-traumatico o, ancora, nelle condotte autolesive, in cui l’esperienza del passato viene come rivissuta nelle relazioni attuali.
Compito di conquista e compito di accompagnamento alla scoperta
Superata e per molti versi tramontata l’idea del bambino beatamente immerso nel suo narcisismo primario, postulato da Freud, pensiamo oggi al nuovo nato come individuo aperto sin da subito alla relazione, già ricettivo agli stimoli ed in grado di rispondervi durante la vita intrauterina. Il desiderio è sin da subito desiderio dell’altro ed il bambino, nella ricerca della relazione, vive nel rapporto e del rapporto con l’altro. Tutti sappiamo altresì che l’infanzia non è mai felice, seppur sussista sempre, per qualsiasi bambino, la possibilità di accedere ad una crescita sufficientemente serena, per molti versi conquistandola. Certamente possibilità non significa certezza.
Posto che la relazione è costitutiva, il rischio dello scacco per la relazione è sempre presente e la frustrazione appare una contingenza inevitabile a cui il bambino fa fronte con le proprie difese, mobilizzando le capacità di resilienza di cui dispone, per colmare le lacune di un desiderio sempre, in parte, impossibile. Il pulsare stesso della vita contiene in sé elementi difensivi, mescolati ad altri elementi. E se le difese più arcaiche ed elementari sono compresenti al gesto vitale, le capacità di resilienza del desiderio spingono il bambino ad apprenderne di nuove, più efficaci e sofisticate, così che, attraverso un gioco di fantasmagoriche e ricche sovrapposizioni, la mente del bambino si sottrae allo scacco della relazione e riesce a seguire i suoi più o meno incerti destini, cioè attiva le proprie risorse, permettendo alla relazione di sottrarsi alla cristallizzazione ed alla sclerosi.
Lasciando ancora in ombra la figura paterna, della cui autorevolezza, dal sapore più o meno castrante, si continua a lamentare l’evanescenza, l’accento della psicoanalisi è caduto sulla figura materna che, ove sufficientemente buona, garantisce i presupposti necessari a che il bambino possa organizzarsi per far fronte all’inevitabile contingenza della frustrazione all’interno delle relazioni primarie. Ma né la madre, né i caregivers più in generale, hanno sempre e naturalmente il dono della capacità di essere sufficientemente buoni. Su questo punto sembra aver oggi richiamato l’attenzione la psicoanalisi, con l’idea di sviluppo traumatico. Perché in una certa misura lo sviluppo è comunque traumatico, o quanto meno è sempre esposto al rischio di esser tale. Ma questa nozione mette altresì in evidenza che la principale funzione dei caregivers consiste nel cogliere l’opportunità loro offerta di rendere più concreta o più probabile, per un bambino, la possibilità di accedere, attraverso un percorso di conquista, ad una crescita sufficientemente serena.
Al bambino il compito difficile della conquista, all’adulto il compito di garantire le condizioni di base perché ciò accada, accompagnando il bambino nella scoperta delle sue risorse.